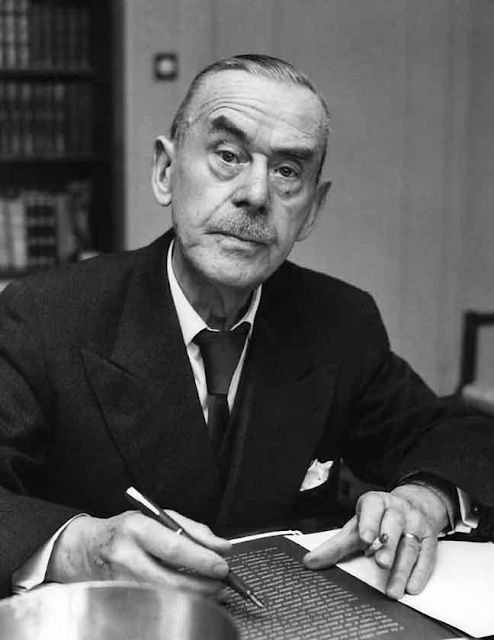Era l'agosto del 2007,18 anni fa,quando l'Italia venne emotivamente colpita da quello che poi sarebbe stato conosciuto come il "caso Garlasco".Nell'antivigilia di ferragosto di quell'anno,il 13 agosto,Chiara Poggi,una ragazza di 26 anni,venne trovata uccisa in una pozza di sangue nella sua villetta di Garlasco,un paese di poco più di 8000 abitanti in provincia di Pavia.Dopo 2 assoluzioni in primo e secondo grado venne dichiarato colpevole Alberto Stasi,fidanzato di Chiara.
Oggi,dopo 18 anni,quel caso è stato riaperto dalla Procura di Pavia,in base a presunti nuovi elementi.Nell'opinione pubblica nazionale si è così creato sconcerto e disorientamento difronte alla riapertura dell'inchiesta che si riteneva chiusa con la condanna di Alberto Stasi.E per chi crede in uno stato di diritto viene da chiedersi:se il "caso Garlasco" è stato riaperto dopo così tanti anni,può essere che altri casi giudiziari del genere siano riaperti ?E se sì quanto è giusto che duri un processo ? E ancora:non si può esser sicuri nemmeno che una condanna inflitta con sentenza passata in giudicato sia giusta e certa ?
Già,perchè a ricordare tutti i "cold case" italiani,tutti i casi giudiziari degli ultimi 40-50 anni restati irrisolti o apparentemente risolti ma che ancora suscitano dubbi e perplessità sulla giustezza delle sentenze,c'è un qualcosa di più generale che sta avvenendo.Avviene cioè che in questo nuovo incerto tempo che viviamo è come se fossimo in un'atmosfera sospesa,un generale clima di azzeramento di entusiasmo e fiducia,di declino,morale e sociale nel quale è maturato un senso diffuso di sfiducia nel futuro e verso le istituzioni del Paese.E nella più generale crisi di fiducia e disistima delle istituzioni,è la giustizia a subirne i danni più rilevanti.E questo è grave per tutta la collettività,perchè in un Paese progredito la giustizia è istituzione irrinunciabile:essa garantisce l’osservanza delle regole,senza distinzione di razza,sesso, religione, appartenenza politica,e quindi uguale per tutti. Il sistema delle norme alla cui tutela la giustizia è posta,disciplina la convivenza civile: allorquando viene violato, si instaura un processo finalizzato a ristabilire l’equilibrio sul quale si incentra il rapporto tra i cittadini.Ed è perciò essenziale che questo meccanismo sia capace di dare risposte corrette:ogni errore non soltanto perpetua la violazione della regola ma crea ulteriori squilibri,suscita risentimento e diffonde sfiducia.
Certo,l’errore è parte dell’agire umano e neppure la giustizia sfugge a questa logica.Ma proprio per l'importanza del suo ruolo,quando la giustizia sbaglia si diffonde lo sconcerto: la responsabilità di chi è stato condannato con sentenza definitiva viene sovvertita. L’illecito, che si riteneva essere stato risolto nella convinzione di avere punito il colpevole,torna a essere un fatto irrisolto.Ed ecco che questa incertezza produce dolore,sfiducia e rabbia:in chi credeva di vedere avuto almeno parziale sollievo con la condanna del responsabile;in chi è stato ingiustamente punito;in chi si trova ora al centro delle accuse.
È quanto è avvenuto con la riapertura del caso del delitto di Garlasco:l’inizio di nuove indagini a distanza di 18 anni sconvolge quella certezza di una giustizia finalmente fatta con la condanna di Alberto Stasi.Ed ora che tutto viene rimesso in discussione è difficile immaginare quali siano i sentimenti dei genitori di Chiara,quale sia la condizione di Stasi che ha già scontato 10 anni di carcere e quale sia la sofferenza di Andrea Sempio,il nuovo indagato.Ma grande è lo sconcerto che s'ingenera anche nel cittadino e che produce sfiducia nella magistratura.
Proprio per evitare situazioni del genere,il legislatore ha introdotto una precisa norma:il giudice condanna solo se l’imputato risulti colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio"(art. 533 Codice Procedura Penale).Ed è questo il cardine di uno stato di diritto:quando le indagini non sono riuscite a fornire la prova certa della responsabilità di un individuo si deve procedere alla sua assoluzione,e quella che potrebbe sembrare la "debolezza" del sistema giudiziario ne rappresenta invece la forza; l’irrisoluzione del delitto è il prezzo che si deve pagare per evitare l’incertezza della condanna, suscettibile di produrre effetti ancor più gravi e dolorosi.E nota è la massima:"meglio un colpevole in libertà che un innocente in galera".
Il caso di Garlasco,allora,non è solo un caso di cronaca giudiziaria.Non è neppure e soltanto la conseguenza di indagini condotte con pressapochismo e superficialità e di un interrogatorio fatto a Stasi con metodi,a dir così,non proprio "garantisti".Forse è "anche" questo ma non è "solo" questo;è soprattutto un’enorme questione posta al cuore dello Stato di diritto e del tessuto della democrazia.
Finora c'è un condannato con sentenza definitiva,Alberto Stasi, che si è sempre proclamato innocente e che due volte è stato assolto, prima di venire condannato definitivamente in Cassazione.Gli avvocati della famiglia della vittima invitano a non rinnovare oltre il comprensibile,straziante dolore della famiglia,e a fermarsi davanti a quella sentenza di condanna per omicidio volontario,pronunciata in base ai principi della Costituzione.Ma pur nel rispetto di quell'indicibile dolore è proprio quella Costituzione che impone che tutti gli imputati siano ritenuti innocenti fino a una sentenza definitiva di condanna che va pronunciata,appunto,“oltre ogni ragionevole dubbio”,e cioè quando i giudici abbiano acquisito la convinzione che la colpevolezza dell'imputato sia così solida da escludere il sia pur minimo dubbio razionale sulla sua responsabilità.Ma quella convinzione di colpevolezza proclamata così forte nel giudizio di Cassazione,così forte poi non è se oggi è la stessa magistratura competente a dubitarne tanto da riaprire l’indagine.
Ecco perchè la riapertura di questo caso mette in luce tutta una serie di questioni politiche ma anche giuridiche e di civiltà del diritto che risaltano dalle parole di alcuni giudici che assolsero Stasi in primo e secondo grado.Quei giudici,commentando oggi i fatti e le decisioni di allora,dicono un qualcosa che sembrerebbe scontato inuno stato di diritto,e cioè che senza la certezza di una colpevolezza,c'è l'obbligo di assolvere.Quei giudici assolsero Stasi non perché era certi della sua innocenza,ma perchè non erano sicuri della sua colpevolezza.E' tutta qui la base di uno Stato di diritto:per assolvere basta un dubbio,per condannare serve la certezza.
Certo,è comprensibile ed umano sentirsi dalla parte della vittima e di chi la piange.E tuttavia, la cifra di una democrazia fondata sullo Stato di diritto si misura principalmente non per come sa dare una consolazione qualsiasi alla memoria delle vittime e ai loro cari, ma per come sa garantire gli imputati, prima e dopo che siano giudicati colpevoli.E cioè non dobbiamo pensarci o sentirci dalla parte di Chiara Poggi o dei suoi cari che giustamente la piangono,ma dobbiamo pensarci imputati alla sbarra per il suo omicidio. Immaginare che potremmo essere noi,da innocenti,a trovarci condannati ingiustamente o che in quella posizione orribile potrebbe trovarsi qualcuno al quale vogliamo bene.
Nelle prossime settimane o forse addirittura nei prossimi anni sapremo quale sarà stato l'epilogo di questo caso.Nello stesso tempo capiremo l'eventuale fallimento o meno di un sistema giudiziario.Ma la cosa più importante,anche se difficile da accettare sarà sempre e solo una:nessuno può essere condannato se non viene superato ogni ragionevole dubbio.Valeva per Stasi,vale per Sempio,e per chiunque altro.Fino ad arrivare all’estrema conseguenza,per cui non potendosi dire con certezza chi abbia ucciso una ragazza nel mezzo di un giorno d'agosto,ci sarà un assassino che sarà libero,ma almeno nessun innocente finirà in galera.Anche questo è Stato di diritto.